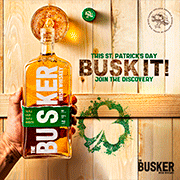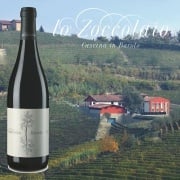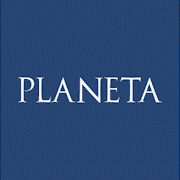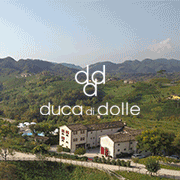Categories
- Abbinamenti
- Accessori
- Altri
- Antipasti
- Antipasti di pesce
- Antipasti estivi
- Antipasti sfiziosi
- Attualità
- Cocktail
- Com'è fatto
- Com'è fatto
- Contorni
- Contorni di verdure
- Contorni sfiziosi
- Curiosità
- Dal Mondo
- Distillati
- Dolci
- Dolci al cioccolato
- Dolci al cucchiaio
- Dolci alla frutta
- Dolci sfiziosi
- Eventi
- Francesi
- Gin
- Grappa
- Guide
- Guide
- In-Rilievo
- Ingredienti
- Italiani
- Personaggi
- Piatti unici
- Primi
- Primi piatti di carne
- Primi piatti di pesce
- Primi piatti sfiziosi
- Produttori
- Rum
- Secondi
- Secondi piatti di carne
- Secondi piatti di pesce
- Secondi piatti sfiziosi
- Sponsorizzato
- Storia
- Storia e società
- Tedesco
- Tequila
- Vegetariani e Vegani
- Vini
- Vitigni
- Vodka
- Whisky